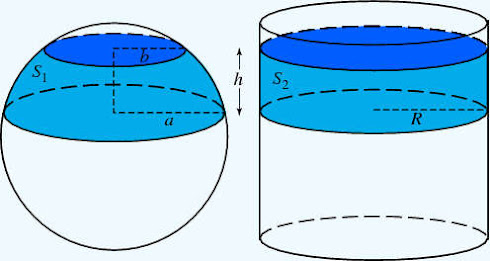ideato da @giorgiosalati!
Secondo la teoria sociologica dei
6 gradi di separazione, ogni persona sulla Terra può essere collegata a una qualche altra persona sulla terra attraverso una catena costituita da cinque distinti collegamenti. Tale teoria venne formulata per la prima volta nel 1929 nel racconto omonimo dell'ungherese
Frigyes Karinthy (forse ispirato da
Guglielmo Marconi e dal suo lavoro sulle onde radio).
A portare per la prima volta l'idea di Karinthy nella scienza ci pensarono
Ithiel de Sola Pool del MIT e
Manfred Kochen dell'IBM che, dopo un lungo lavoro di studio sulle reti sociali iniziato negli anni Sessanta del XX secolo, produssero i loro risultati nel volume
Contacts and Influences.
I due cercarono di matematizzare la questione:
Dato un insieme di $N$ persone, qual è la probabilità che ogni membro di $N$ sia connesso a un altro membro attraverso $k_1$, $k_2$, $k_3$, ..., $k_n$ collegamenti?
Parte del loro lavoro fu anche lo sviluppo di una
simulazione Monte Carlo basata sui dati raccolti da
Michael Gurevich nei suoi studi sulle reti sociali. A partire dal lavoro di Gurevich,
Stanley Milgram sviluppò la così detta
teoria del mondo piccolo, nome assegnato in origine proprio da Kochen e Pool per la loro ipotesi dei sei gradi di separazione.
Il mondo è piccolo, si sa!
Secondo tale modello, due nodi qualunque all'interno di una rete finita, per quanto grande, sono collegabili da un numero relativamente piccolo di passi. Milgram sviluppò le sue idee e propose i dati raccolti in due articoli, uno di esposizione divulgativa sul primo numero di
Psychology Today del 1967
(1), quindi due anni più tardi in una esposizione più rigorosa condotta insieme con
Jeffrey Travers sulle pagine di
Sociometry(2). Di fatto i due ricercatori seguirono innanzitutto l'approccio matematico di Kochen e Pool per definire i termini del problema, ridotto a porsi la domanda:
Quale è la probabilità che due qualsiasi persone, selezionate arbitrariamente da un'ampia popolazione, come quella degli Stati Uniti, si conoscano una con l'altra?
A partire da questa domanda si può formulare il problema in termini più interessanti, ovvero cercare di capire quali sono le conoscenze comuni che potrebbero metterli in collegamento uno con l'altro. Quindi si generalizza il problema con la ricerca di un insieme $B$ di individui $b_1$, $b_2$, ..., $b_k$ conoscenze comuni di due dati individui $a$, $z$. E' però possibile generalizzare ulteriormente, ovvero chiedersi se più in generale non esista un insieme $C$ in maniera tale che il collegamento sia $a$ con un individuo $b_i$ di $B$, quindi il generico $b_i$ con un individuo di $C$, e infine il generico $c_j$ con $z$. Il problema nella massima generalizzazione è dunque cercare quanti intermediari sono necessari in media per costruire una
catena di conoscenze tra $a$ e $z$.
Provando a portare la ricerca con un esperimento sul campo ecco che:
Il numero medio di intermediari osservati in questo studio era superiore a cinque; una ricerca aggiuntiva (di Korte e Milgram(3)) indica che tale valore è abbastanza stabile, anche quando vengono introdotti incroci razziali.(2)
Questi risultati, come è ovvio, hanno ricevuto un certo numero di critiche, come ad esempio l'esistenza di gruppi più o meno piccoli di esseri umani isolati dal resto del mondo. In realtà ciò, semplicemente, rende velleitaria l'idea di voler generalizzare il
mondo piccolo a tutto il pianeta, ma non che le cose funzionino così in un suo sottogruppo. I gradi di separazione, al contrario, se studiati opportunamente, permettono di comprendere il potenziale sociale di una comunità. Ad esempio il concetto di grado di separazione è, in effetti, fondamentale per i
social network, ed è stato scoperto che su twitter questo risulta essere in media di 3.43
(4).
I numeri di Erdos e Bacon
La diffusione del
mondo piccolo e dei 6 gradi di separazione è essenzialmente dovuta a una serie di concause, che partono dalla commedia teatrale del 1990 di
John Guare, che a sua volta è stata portata sul grande schermo nel 1993 da
Fred Schepisi (tra gli attori un giovane
Will Smith), per poi arrivare al
numero di Bacon. Questo numero indica il grado di prossimità di un qualunque attore da
Kevin Bacon ed è, racconta la leggenda, ispirato a un'affermazione che l'attore avrebbe concesso a un giornalista nel 1994, secondo cui egli avrebbe lavorato con tutti gli attori di Hollywood o con qualcuno che ha lavorato con loro. Il gioco, proposto da tre studenti dell'
Albright College,
Craig Fass,
Brian Turtle e
Mike Ginelli, mirava a verificare l'affermazione di Bacon, ma di fatto ha introdotto un numero che misura la prossimità di qualunque elemento a un centro arbitrario.
Il numero di Bacon è definito così: Kevin Bacon stesso ha un numero pari a 0, attori che hanno lavorato con lui hanno un numero pari a 1, attori che hanno lavorato con questo gruppo ma non con Bacon hanno numero pari a 2, e così via.
Più o meno nello stesso modo funziona l'altro numero famoso in questo gioco dei
mondi piccoli: il
numero di Erdos.
Paul Erdosè stato il matematico più prolifico e collaborativo del XX secolo. Per omaggiarlo venne proposto un numero, evidentemente legato alle catene del
mondo piccolo, che indicasse il grado di prossimità nella catena di collaborazione: funziona proprio come il numero di Bacon e la discriminante è aver scritto un articolo con Erdos o con qualcuno che ha scritto un articolo con Erdos o con qualcuno che ha scritto un articolo con qualcun altro che ha scritto un articolo con Erdos e così via.
Di fatto anche il numero di Erdos, così come quello di Bacon, aveva all'inizio il carattere del gioco, anche se oggi viene utilizzato per testare il grado di collaborazione della comunità matematica.
Paperino e i sei gradi di separazione
Il senso del gioco dietro i sei gradi di separazione e il mondo piccolo così chiaro ai matematici, viene sfruttato splendidamente da
Giorgio Salati in
Paperino e i 6 gradi di separazione, storia apparsa su
Topolino 3138 per i disegni di
Antonello Dalena. L'avventura, divertente e dal ritmo incalzante, ruota intorno alla ricerca da parte di Paperino di avvicinare il suo regista preferito, West Anatranson, versione
disneyana di
Wes Anderson.
Grazie a ciò, Salati riesce a stuzzicare il lettore grazie a una serie di citazioni cinematografiche, come il
Grand Budapest Hotel che diventa il
Grand Paperopoli Hotel, o allo stile di Anderson, in particolare alla sua passione per le inquadrature simmetriche.
Nel suo tentativo di avvicinarsi ad Anatranson, Paperino incontra anche due attori, Andie MacDuckell, versione papera di
Andie MacDowell, e Bill Duckray,
disneyzzazione di
Bill Murray, uno dei protagonisti di
Ghostbuster, film citato nelle scene ambientate nella villa di Duckray. Il livello di cura cinematografica con cui la storia è stata scritta, lo fornisce però il titolo del film dove Duckray e MacDuckell hanno recitato insieme,
Il giorno della nutria, che di fatto si riferisce al titolo originale di
Ricomincio da capo, ovvero
Groundhog Day.
Il gustoso inseguimento, sebbene non coroni il sogno di Paperino di recitare in un film di Anatranson, porta il gruppo di conoscenze raccolte nel corso della ricerca sul set del primo film da regista di Duckray,
Paperello e i 6 gradi di separazione, che per certi versi chiude il cerchio non solo con il titolo della storia di Salati e Dalena, ma anche con le citazioni cinematografiche, visto che
I 6 gradi di separazioneè non solo una commedia teatrale, ma anche una pellicola cinematografica.
In conclusione: una bella e stuzzicante avventura, ricca di spunti per il lettore adulto, ma piacevole e divertente anche per i più giovani: il giusto mix per una storia di
Topolino.
(1) Milgram, S. (1967). The small world problem.
Psychology today, 2(1), 60-67. (
pdf)
(2)
Travers, J., & Milgram, S. (1969). An Experimental Study of the Small World Problem Sociometry, 32 (4) DOI: 10.2307/2786545 (
pdf)
(3) Korte, C., & Milgram, S. (1970). Acquaintance networks between racial groups: Application of the small world method.
Journal of Personality and Social Psychology, 15(2), 101. (
pdf)
(4) Bakhshandeh, R., Samadi, M., Azimifar, Z., & Schaeffer, J. (2011, May).
Degrees of separation in social networks.
In Fourth Annual Symposium on Combinatorial Search.
![]()